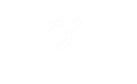Deborah Feldman (1986) è nata nella comunità chassidica di Williamsburg. Cresciuta dai nonni paterni, sin da piccola fatica ad attenersi alle severe regole della comunità ultraortodossa, trovando rifugio e conforto unicamente nella letteratura. Dopo un matrimonio combinato e la nascita del figlio, inizia a frequentare un college di nascosto; in seguito dà vita a un blog che si rivelerà il trampolino di lancio del bestseller Unorthodox. Trova così la forza di abbandonare per sempre la comunità. Dopo Unorthodox dà alle stampe Exodus. È una delle protagoniste del pluripremiato documentario di Barbara Miller Female Pleasure. Da qualche anno vive a Berlino con il figlio.
La comunità chassidica Satmar di Williamsburg, New York, si distingue fra i gruppi ultraortodossi ebraici per le sue regole severe. Poiché i Satmar vedono l’Olocausto come una punizione divina, per evitare che la Shoah si ripeta vivono un’esistenza schermata e scandita dai riti. La sessualità rappresenta un tabù, i matrimoni sono combinati e nella vita di tutti i giorni si parla in yiddish, poiché l’inglese è proibito.
Deborah Feldman fatica sin da piccola ad adattarsi allo stile di vita severo e alla posizione inferiore della donna all’interno della comunità religiosa in cui nasce e cresce. Il suo senso di giustizia e la sete di conoscenza la portano a mettere in discussione il mondo che la circonda; in questo è rafforzata dalla letteratura, a lei proibita. Ex ortodossa è un memoir che racconta l’impressionante processo di emancipazione di una donna che riuscirà a trovare la propria identità, e con essa la libertà.
ISBN: 9788890770951
Prezzo: CHF 25.-
Pag.: 300
INTERVISTA A DEBORAH FELDAMAN
Deborah Feldman, quali erano le aspettative al momento della prima pubblicazione del libro negli Stati Uniti?
Deborah Feldman: Si optò per un’edizione ridotta, che andò subito esaurita, e si dovette attendere un mese per la ristampa. Un errore di valutazione che molti trovarono scandaloso nel mondo dell’editoria. Il libro fu poi portato a Francoforte, dove suscitò un grande interesse, anche se non si sapeva bene come presentare l’argomento in Europa, poiché la comunità chassidica, pur avendo radici europee, è quasi del tutto scomparsa. C’era il rischio che i lettori non comprendessero fino in fondo l’importanza di questa storia. Ora che abito in Europa e ho potuto riconnettermi alle mie radici europee, credo che le persone abbiano finalmente un contesto di riferimento. Il libro è andato molto bene in Germania, ma credo che ciò sia dovuto anche alla mia presenza. Ho creato dei legami all’interno della società tedesca, vado in televisione e alla radio, aprendo così dei canali di comunicazione. Non sono semplicemente un’autrice in visita dagli USA, poiché mi sono trasferita definitivamente. Spero che si riesca a riconoscere l’universalità della mia storia.
LA QUESTIONE DELL’IDENTITÀ
Fino a qualche anno fa Deborah Feldman era una sconosciuta. Sei cambiata dopo il successo, e chi sei oggi?
Tecnicamente parlando Deborah Feldman non è il mio vero nome. In realtà ho un nome ebraico oltre a un nome d nubile. Ho mantenuto il cognome di mio marito perché è anche quello di mio figlio. Il mio vero nome è Sara Berkowitz. Il nome Deborah mi affascinava perché era riportato anche sul mio certificato di nascita, sebbene nessuno in famiglia portasse quel nome e gli ebrei ashkenaziti abbiano l’usanza di dare ai figli i nomi di parenti deceduti. Ho fatto delle ricerche nell’albero genealogico della famiglia, ma non sono riuscita a trovare nessuna Deborah. Sarah è la matriarca ebraica per definizione, stava sempre nella sua tenda, era modesta e obbediente. Deborah è stata l’unica donna ebrea a raggiungere la notorietà e un certo potere, era giudice e comandante militare, non si è mai sposata ed era molto indipendente. Era considerata investita dal potere di Dio e dal potere della gente, e ho pensato che trovarla sul certificato di nascita non potesse essere frutto di una coincidenza. Ho cominciato a usare il nome Deborah quando mi sono iscritta al college, momento in cui mi sono accorta che sul certificato di nascita era quello il nome riportato.
Ma chi ti ha dato il nome Deborah?
Nessuno lo sa con certezza. Ne ho parlato con mia madre, mi ha detto che all’ospedale le avevano chiesto come volesse chiamarmi, ma non ricorda di avere detto quel nome. Forse c’è stato un malinteso.
Ho poi scoperto che nella comunità ebraica succede che la gente abbia dei nomi diversi sul certificato di nascita, ma credo che Deborah sia un nome speciale, per cui l’ho visto come una specie di omen, di segno. Per me rappresenta il simbolo della trasformazione di un’identità in un’altra.
Sono diventata una persona nuova e mi sono liberata della mia vecchia identità. Ho cercato di ricostruirne una nuova. Ora che ho superato i trent’anni e ho un figlio, vivo a Berlino, dove scrivo e leggo. Conduco comunque una vita semplice e riflessiva. Un tempo ero definita dai riti, dalla routine e dalle scadenze, dal peso della storia e dall’eredità etnica. La trasformazione maggiore è data da chi ero e chi sono adesso, e sebbene abbia ancora un forte legame con la mia eredità e con la storia, questo si è trasformato in un sostegno e non rappresenta più un fardello.
La relazione con la tua identità è cambiata.
Sì, perché ho inventato una nuova identità. Questo significa che sono più libera, ma anche più normativa. Ora faccio parte del mainstream, il che per me è una buona cosa. Non ho mai voluto essere speciale. Credo che il desiderio dei bambini di essere speciali in realtà sia un meccanismo di sopravvivenza, in grado di compensare le mancanze. A un certo punto ti dici: la tua vita è infelice, ma sei una persona speciale. Nel momento in cui vedi che i tuoi bisogni fondamentali sono soddisfatti e i tuoi diritti sono rispettati, il desiderio di essere speciale sparisce automaticamente.
Ti riferisci al fatto che eri in qualche modo speciale nella tua comunità?
Da una parte sì, mi sentivo speciale, dall’altra c’erano i protagonisti dei libri che leggevo da bambina: soffrivano tutti ma erano speciali, avevano un destino speciale. Dunque, dicevo a me stessa, probabilmente soffrivo perché avevo in serbo un destino speciale, che mi avrebbe compensato di ogni mancanza. Ora sono giunta a un punto della vita in cui posso rilassarmi, e mi rendo conto che non ho più bisogno di essere speciale. Per me è la prova che ho fatto dei progressi, che non ho più bisogno di compensare.
Oggi puoi affermare di essere la persona che desideravi?
Quando parliamo di chi siamo diventati ci riferiamo al carattere. E in questo senso il cambiamento è un work in progress. Io sto cercando di avere un carattere migliore e ho finalmente trovato la voce che ho sempre desiderato. Il processo di trovare la propria voce interiore libera da ogni influsso esterno avviene lentamente.
UNA NUOVA ESISTENZA IN EUROPA
Quando hai deciso di andartene dagli Stati Uniti avevi già dei legami altrove?
L’aspetto più incredibile della mia vita è che non ho dei legami, o perlomeno non in un’accezione tradizionale; ho dovuto adattarmi alle circostanze, imparando a instaurare dei legami in poco tempo, a farmi velocemente nuovi amici, e a imparare le lingue e comprendere le culture senza sforzo. Prima di venire a Berlino, pur avendo qualche conoscenza qui, ho capito che non avrò mai quei legami che gli altri danno per scontati, poiché ho dovuto imparare a vivere senza. Spesso creo dei legami immaginari con l’arte e con gli artisti, è un processo grazie al quale riesco ad avvicinarmi a un determinato posto. Da quando ad esempio ho letto le opere di Primo Levi, che è il mio autore preferito, provo un grande fascino per Torino, e ho così creato dei legami con la città che fa da sfondo alla sua produzione. In questo senso anche Berlino offre grandi risorse a livello creativo.
Ti sei trasferita a Berlino definitivamente?
Certo, e mi hanno offerto anche la cittadinanza. Avevo fatto richiesta di cittadinanza qualche anno fa, rifacendomi ai miei nonni. All’inizio è stato difficile, ma poi, grazie alla popolarità ottenuta con il mio libro, le cose sono andate più velocemente.
Qual è il tuo rapporto con la cultura europea?
Nel 2012 durante il periodo di Natale ho visitato Roma insieme a mio figlio. Poiché conosceva solo gli aspetti commerciali tipicamente americani del Natale, volevo che ne scoprisse il vero senso. Anche se siamo ebrei e non festeggiamo il Natale, non volevo privarlo di nulla, così gli proposi di addobbare un albero e di scambiarci dei doni. Ma volevo anche spiegargli le origini della tradizione, così ho deciso di portarlo a Roma, che è la capitale del cristianesimo. Purtroppo, a Natale è tutto chiuso, e così siamo rimasti nel ghetto ebraico, un’esperienza che mi ha toccata in profondità. Ho infatti trovato che la cultura ebraica romana è diversa dalle altre culture ebraiche, e al contempo si distingue anche dalla cultura italiana. Ho conosciuto la famiglia che gestisce il ristorante Nonna Betta, la cui storia va indietro di secoli, e ho avuto l’impressione che nella comunità ci fossero un equilibrio e un’intimità più grandi che altrove. Sebbene vi sia una certa tensione fra cristianesimo ed ebraismo, la sensazione è che all’ebraismo sia comunque riconosciuto il fatto di essere alle origini della cristianità. Vi ho riconosciuto una forma di rispetto.
PROGETTI FUTURI E INTELLETTUALI
A cosa stai lavorando al momento?
È piuttosto complicato, nel 2014 ho iniziato la stesura di un romanzo ispirato dalla generazione di scrittori appartenenti al periodo successivo alla Seconda guerra mondiale. Mi sono resa conto che molti di loro si sono suicidati, oltre a Primo Levi si sono infatti tolti la vita Jean Améry e Paul Celan, e forse anche Nelly Sachs. Vi sono poi autori come Imre Kertesz che, pur non essendosi suicidato, ha deciso di non mettere al mondo dei figli. Forse la decisione di non investire più nell’energia vitale e di recidere la propria, di energia, è la risposta alla consapevolezza di avere visto gli abissi in cui può sprofondare il genere umano. Il romanzo inizia con un gruppo di artisti ispirati da quegli autori che hanno stretto un patto suicidale, e a quel punto inizia una lotta tra l’intellettualismo e il fatto che proprio l’intellettualismo possa rappresentare un ostacolo alla vita.
In questo mi riallaccio alla mia esperienza, al fatto che la mia comunità considerasse pericolosi i libri. Mi chiedo quale sia il loro ruolo effettivo in termini di storia, educazione e cultura. È un modo per guardare le cose da una prospettiva diversa: cosa sarebbe successo se i miei nonni avessero del tutto rifiutato Dio e la religione, se avessero deciso che la vita non avesse più alcun senso, che non ci fosse più nulla per cui valesse la pena di vivere… come sarebbe stata la vita se fossi cresciuta con un’influenza di quel tipo?
Qual è il tuo rapporto con gli intellettuali?
Da una parte promuoviamo le parole degli intellettuali sottolineandone l’importanza, ma dall’altra credo non vi sia simbolo di impotenza più grande di quella degli intellettuali. Pur dovendo produrre senza sosta, parlare e condividere, sono costretti ad assistere all’impotenza del proprio linguaggio, dei propri pensieri e della propria opera. Questo crea una sofferenza con cui è difficile convivere.
Io stessa lotto costantemente per capire quale sia il mio scopo di scrittrice. Perché lo faccio? Perché credo che scrivere sia importante? Perché credo di dovere essere ascoltata? Sto cercando delle risposte. Ho sempre cercato di rendere la scrittura un rituale umano quotidiano e non qualcosa di intellettuale o di elevato.
Dunque la scrittura deve essere accessibile?
Quando frequentavo l’università negli Stati Uniti ho capito il concetto della torre d’avorio. Mi sono resa conto che studiavo cose meravigliose, che però non avevano alcuna applicazione di ordine pratico ed erano inaccessibili per chi non era ancora stato iniziato a questo mondo. Non mi piace questa specie di classismo culturale e lo combatto.
Credo che non esista più un ponte che colleghi quella torre con il resto del mondo, e che quindi la nostra cultura intellettuale sia diventata del tutto astratta e impotente, come un arto amputato dal resto del corpo, che è la società. Ma a questo punto la cultura diventa inutile.
Quando ho scoperto questa cosa sono rimasta molto delusa poiché nutrivo grandi speranze: avevo sempre creduto che l’educazione rappresentasse la mia salvezza, e di conseguenza anche quella degli altri. Quando ho capito che non avrei trovato ciò che cercavo, non sapevo dove rivolgermi. Ma alla fine ho capito che dovevo cercare dentro di me e nei libri scritti dagli autori che ammiro. È difficile, perché ancora oggi sento un profondo distacco dal mondo in cui vivo.
LIBERARE LE DONNE DAI TABÙ
Ritorniamo al tuo successo. Il tuo libro può essere letto a diversi livelli: è una biografia, un testo letterario, ma anche un incoraggiamento per le donne che si trovano nella situazione in cui eri tu. Come ti fa sentire questo?
Ovviamente sono contenta di incoraggiare altre donne a prendere posizione. Durante la scrittura del libro mi rendevo conto che sarebbe potuto servire anche a questo, e le reazioni con cui è stato accolto me l’hanno confermato. Il mio scopo principale però era quello di permettere al lettore di capirmi; desideravo prima di tutto diventare un personaggio pubblico, in modo da ottenere l’affidamento di mio figlio.
Desideravo inoltre trovare le parole giuste per esprimere la mia esperienza dal mio punto di vista. L’ho fatto in modo non convenzionale, come si vede dai passaggi in cui descrivo la mia sessualità. Volevo infatti una voce personale, non necessariamente gradevole o attraente, e nemmeno romantica o drammatica. Per questo ho descritto le mie esperienze in modo quasi clinico, e credo di averlo fatto per il semplice desiderio di spronare altre donne a farsi avanti e a dire: “Sai cosa? Ho fatto un’esperienza simile alla tua, e riesco a parlarne anch’io in modo schietto, senza vergogna o artificio”. Credo si trattasse di un traguardo inconsapevole, ma da allora sono stata contattata da molte donne che mi hanno raccontato le loro esperienze e con il tempo ho constatato un leggero cambiamento: la gente della mia comunità ha cominciato a parlare di sessualità, e per me è una cosa importante.
Anche se viviamo in una società piuttosto libera, spesso alle donne viene ancora imposto un determinato linguaggio. Quando lesse il manoscritto per la prima volta, il mio editore tedesco mi chiese il permesso di omettere i passaggi dedicati alla sessualità, poiché secondo lui i tedeschi non avrebbero apprezzato. Ma io avevo scritto il libro proprio per quel motivo, per parlarne. Volevo che ci si liberasse dalla sensazione di disagio che si prova quando si sente una donna parlare di sesso.
Credi che assisteremo mai a un cambiamento radicale? In Ex ortodossa citi l’autrice Pearl Abraham, il cui libro apparve per la prima volta negli anni Novanta. A Pearl Abraham è poi seguita Judith Rothem, con Lo strappo, mentre recentemente è stata riscoperta anche la sorella dei fratelli Singer, Esther.
Stiamo assistendo a un cambiamento in questo senso?
Le cose sono effettivamente cambiate, e la differenza l’ha fatta la tecnologia. In Israele c’è un movimento importante, la gente ha cominciato ad andarsene. Purtroppo però la percentuale di fallimento è alta tra chi cerca di lasciare la comunità. È toccante l’esempio dell’israeliana Esti Weinstein, cresciuta nella comunità chassidica di Gur. Dopo essersi sposata e avere avuto numerosi figli, ha deciso di lasciare la comunità, lottando a lungo per trovare la propria pace interiore. La famiglia e i figli però non la lasciavano in pace, e alla fine Esti si è suicidata. Prima di morire ha scritto un manifesto, una specie di j’accuse in cui elenca tutto quello che l’ha fatta soffrire. In Israele questa storia ha sollevato molti interrogativi, poiché Etti ha descritto il modo in cui le autorità delle comunità ortodosse calpestano i diritti delle donne e dei bambini al punto da privarli di ogni risorsa. Per queste persone diventa difficile riuscire ad arrangiarsi da sole.
Questo succede anche in America. Qualche tempo fa ho sentito la storia di una giovane donna che ha lasciato la comunità più o meno nel periodo in cui l’ho fatto io, ma la sua famiglia non ha mai smesso di perseguitarla sul piano psicologico. Era un rischio di cui ero consapevole anch’io, e contro il quale ho cercato di proteggermi il più possibile. Ma se, come nel caso della ragazza americana, non hai qualcuno in grado di sostenerti e di darti stabilità una volta lasciata la comunità, ci vuole poco per arrivare al limite, ed è per questo che alla fine la ragazza si è gettata da un grattacielo finendo su un marciapiede di Manhattan. Credo che si sia suicidata in quel modo perché voleva fare una dichiarazione, voleva che se ne parlasse.
Da allora si è mosso qualcosa a favore delle donne?
L’attenzione nei confronti di questo argomento è cresciuta molto. Ora c’è la consapevolezza che si tratta di un problema, ma mancano ancora le soluzioni, o un sistema di sostegno. Comunque sia, tutti questi casi dimostrano che la porta è stata aperta, e che è giunto il momento di creare un percorso valido per tutte le società che hanno a che fare con il fondamentalismo, senza limitarci a quella ebraica. Si sente dire di continuo che, nel mondo occidentale, chiunque cresca in una “parasocietà” religiosa sia tecnicamente libero di andarsene, ma allo stesso tempo, mancano le risorse per chi decide di andarsene, non c’è alcuna protezione da eventuali ritorsioni, e mancano il supporto e l’ascolto.
Anche se la libertà dovrebbe essere protetta dalla Costituzione, per esperienza personale so che non è così, che è solo teoria. Nella vita vera i politici fanno finta di non vedere che i diritti vengono calpestati, poiché l’unico interesse è rivolto ai voti delle comunità religiose. I miei diritti civili non interessavano a nessuno. A questo si aggiunge un altro problema: in nome della tolleranza e del multiculturalismo la società è disposta ad accettare situazioni che in realtà sono inaccettabili.
Com’è il rapporto della tua ex comunità con la tecnologia?
Ovviamente all’inizio hanno cercato di controllarla, ma è praticamente impossibile. Per la prima volta esiste la possibilità di gettare uno sguardo al mondo esterno, considerando così le proprie opzioni personali. Un tempo ciò non era possibile, e i rischi erano di gran lunga maggiori. In questo senso le cose sono cambiate molto.
Sono più gli uomini o le donne che lasciano la comunità chassidica?
Gli uomini che se ne vanno sono molto più numerosi delle donne, forse perché le donne vengono sposate giovani e poi hanno subito dei figli cui sono legate. È difficile lasciare la comunità per entrambi: la formazione e le risorse sono scarse. Gli uomini però se ne vanno per motivi diversi dalle donne: tirano sempre in ballo una crisi di fede, a un certo punto si rendono conto che forse Dio non è come lo descrivono, o che forse non c’è del tutto, e allora subentra la crisi che impedisce loro la pratica quotidiana della religione, poiché non si riconoscono più in dei rituali in cui non credono. A quel punto decidono di andarsene.
Non ho mai sentito nessuna donna parlare di questo. La maggior parte delle donne che se ne vanno pensano a Dio solo in un secondo momento. Le donne non si occupano di questioni riguardanti la presunta esistenza di Dio o la sua natura. Le donne se ne vanno perché si sentono limitate, oppresse, non hanno modo di decidere niente e non possono controllare la propria vita né quella dei propri figli – che spesso non sono nemmeno in grado di leggere. Si sentono minacciate e abusate, e se ne vanno per questo, non per una crisi di fede. È questa la grande differenza.
Leggendo il tuo libro si ha l’impressione che nella tua ex comunità serpeggiasse una violenza silenziosa e latente… è come se il pericolo fosse sempre dietro l’angolo.
Sono cresciuta con la sensazione che intorno a me vi fosse della violenza, ma nessuno ne parlava. Sono stata fortunata perché i miei nonni non sono mai stati violenti con me, ma nella nostra comunità vi sono sia la violenza fisica sia quella psicologica. Le persone vengono forzate e obbligate a comportarsi in un certo modo con ogni mezzo, ma è una cosa di cui non parla nessuno. Ho la sensazione che il fenomeno stia crescendo, forse anche a causa di certi rabbini, che incitano l’odio verso chi è diverso, come i gay o gli ebrei secolari. Con i loro discorsi legittimano l’aggressività in chi si sente già particolarmente oppresso.
La tua vita è cambiata dopo la nascita di tuo figlio e del tuo libro. La fame di libri che ti accompagna sin dall’infanzia si è nel frattempo sopita?
È durata ancora a lungo, ma con il tempo ho capito che a ognuno manca qualcosa e che anche questo fa parte della vita. Ora sono in grado di vivere il presente e tutte le porte sono aperte. Posso fare tutte le esperienze che voglio, e ciò che è successo in passato non ha per forza effetto su di me. Al di fuori di quando scrivo, non penso mai al passato, è come se la scrittura mi avesse separato dal passato creando una distanza.
Mi è però rimasta la curiosità riguardo al passato, al modo in cui si è formata la mia comunità, a quello che avevano passato i miei nonni nel momento in cui sono entrati a farne parte. Mi incuriosisce il passato lontano, e ciò che mi lega ad esso. Scrivendo il primo libro sono riuscita a seppellire la sensazione di perdita. Ora ho tutto ciò che ho sempre voluto.
Hai comunque dovuto mettere in campo una grande forza: non hai abbandonato solamente il luogo in cui sei nata, ma anche le persone che avevano vissuto con te durante i primi vent’anni della tua vita, e in più cresci tuo figlio da sola.
Credo che per il fatto di avere sempre letto dei libri, i miei pensieri più intimi mi abbiano portato a sviluppare una personalità introversa. Sono ancora così, non ho bisogno di molte persone, perché le cose succedono ancora nella mia testa, e la relazione con i libri mi ha permesso di separarmi dalla gente. A volte il rapporto con i personaggi letterari mi sembrava più forte di quello con la mia famiglia.
© 2022 ABENDSTERN EDIZIONI